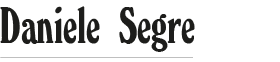Morando Morandini – Cine Critica Aprile-Settembre 2005
Ho accettato di scrivere di Daniele Segre non benché, ma proprio perché sono suo amico, tant’è vero che posi una condizione: ne scriverò da amico, non da critico, pur cercando di conservare la lucidità che s’ha da avere anche verso gli amici. Non avevo ancora vent’anni quando decisi che bisogna fare molto l’amicizia, come si dovrebbe fare molto l’amore. Vent’anni più tardi imparai un proverbio inglese secondo il quale occorre scegliere gli amici dieci anni prima del giorno in cui possono servirti, ma non darei torto a chi mi replicasse che è anche una sorgente della mentalità mafiosa. Nella vita bisogna correre qualche rischio e mettere in conto i fraintendimenti maligni. Come potrei, d’altronde, fare il critico con Segre di cui conosco all’incirca poco più della metà di quel che ha fatto?
Daniele Segre (Alessandria, 1952 – anagraficamente potrebbe essere mio figlio) è un autore di cinema della realtà, di film di finzione e di spettacoli teatrali. Così lui si autodefinisce. (Attenzione: si risente se lo chiamano documentarista, e ha i rancori lunghi). Cinema della realtà? Bastano i titoli dei suoi primi video – ma anche dei successivi – per spiegarlo: Perché droga? (1976), Il potere dev’essere bianconero (1978), Vite di ballatoio (1984). Partito dalla fotografia, nel 1980 pubblica da Mazzotta il libro fotografico “Ragazzi di stadio”. L’anno dopo fonda la società di produzione I cammelli, un nome che è un programma. Nel 1983 autoproduce, scrive e dirige il suo primo film lungo: Testadura, esposto alla Mostra di Venezia. Lodovico Stefanoni, un giovane critico di talento che se ne andò troppo presto, ne scrive così su Cineforum (n. 227): «il regista, che ha messo nel film un pezzo della propria vita personale e la propria casa, gli amici e le loro “menate”, la grigia concretezza di Torino e la precarietà del sopravvivere, è riuscito a fissare con angosciata fissità un pezzo del riflusso, condensando tutti i tic e la retorica dello psicologismo sinistrese […]. Ogni tanto un po’ di ironica autocommiserazione […] ma anche rabbia trattenuta: questo qui impietoso nell’autorappresentazione – talvolta naïve – dei personaggi guarda anche a un altrove non fatto solo di verbose dichiarazioni».
Nel 1984 vince il Gabbiano d’oro della 2^ edizione di “Anteprima per il cinema indipendente italiano” a Bellaria-Igea Marina con Vite di ballatoio. Con Gianni Volpi ed Ettore Zocaro, facevo parte della direzione artistica che aveva selezionato i quindici film in concorso, ma pure della giuria, composta anche da Dario Zanelli, presidente, Goffredo Fofi e Tinin Mantegazza. Motivazione: «per il rispetto e la delicatezza con cui descrive un gruppo di persone emarginate e il loro ambiente». Fu la prima e l’ultima volta che, in quello che ora si chiama BFF (BellariaFilmFestival), i selezionatori fecero anche da giudici, un’anomalia in parte giustificata dalla scarsità dei finanziamenti: bisognava risparmiare un po’ dappertutto. Due giorni dopo la premiazione pubblicai su “Il Giorno” un bilancio critico della rassegna che cominciava con una dichiarazione di Segre: «Essere indipendenti significa essere protagonisti del proprio lavoro fino in fondo». Che, come definizione della fumosa nozione di indipendenza nel cinema, non è male. In quell’occasione furono dati altri due Gabbiani: a Massimo Mazzucco (Summertime) e a Silvio Soldini (Drimage, Paesaggio con figure) ex-aequo e a Venerdì sera, lunedì mattina di Alberto Chiantaretto e Daniele Pianciola. Almeno uno di questi quattro ha fatto strada.
Nel 1982 Segre apre a Torino l’attività della Scuola video di documentazione sociale che negli anni ’90, col sostegno dell’Unione Europea e del Ministero del Lavoro, avvia decine di giovani alla difficile attività di professionista audiovisivo nel sociale. E’ il quarto lato della sua attività, l’insegnamento. Se si tiene conto dei corsi di regia alla Scuola Nazionale di Cinema a Roma (nome del corso: Cinema e realtà) e della sua condirezione del BellariaFilmFestival del 2002, quelle decine di giovani superano il centinaio.
L’ho visto in azione con i ragazzi, provenienti da diverse scuole di cinema, che a Bellaria partecipano alla fabbrica del videomagazine quotidiano. Sa usare con disinvoltura la tecnica del bastone e della carota, capace di sfuriate clamorose con chi sbaglia o non s’impegna abbastanza. Ma pronto pochi minuti dopo a consolare le sue vittime con parole appropriate. A guardarlo dall’esterno, non si capisce mai bene dove finisca la severità e dove comincia la recita della severità. Dosa con sagacia il piglio di ruvido autoritarismo piemontese e i metodi di una saggia maieutica per cavare il meglio da ciascuno. Subordina la teoria alla pratica. Non impapocchia nozioni, insegna a fare. E’ un docente concreto. (La verità concreta di B.Brecht).
Negli anni ’90 i suoi documentari si chiamano Partitura per volti e voci – Viaggio tra i delegati CGIL, 1991 – in onda su Rai3); Dinamite (1994) sui minatori sardi del Sulcis; Come prima, più di prima, t’amerò (1995) sui sieropositivi e i malati di AIDS, Sto lavorando? (1998) sull’inserimento nel mondo del lavoro di un giovane con gravi problemi psichici; A proposito di sentimenti (1999) sull’affettività nei giovani colpiti da sindrome di Down.
Nel 1992, con l’aiuto dell’art. 28, fa il suo secondo film lungo di fiction: Manila paloma bianca, nato dall’amicizia con l’attore milanese Carlo Colnaghi che, dopo varie esperienze teatrali, era uscito dal giro, inghiottito da una nevrosi che portò a un fitto andirivieni tra un ospedale psichiatrico e l’altro. E’ difficile distinguere nel film la finzione scenica del personaggio di Carlo Carbone dalla realtà esistenziale di Carlo Colnaghi: qual è la linea di separazione tra normalità e patologia? Tra eccesso di sensibilità e malattia mentale? Tra dolore e recitazione del dolore? Quali rapporti tra arte e follia? Tra amore e pietà? Fin dove il teatro – l’essere attore – è il portatore sano di una tendenza alla schizofrenia e in che misura ne è la sua medicina? Il fascino spigoloso di Manila paloma bianca scaturisce dal susseguirsi inquietante di queste domande senza risposta.
Sulla linea del cinema della realtà il suo lavoro prosegue nel nuovo secolo. Oltre alla serie Tv Protagonisti. I diritti del Novecento, nel 2000 realizza Via Due Macelli, Italia. La sinistra senza Unità che anticipa il dibattito autocritico sulla sinistra italiana e gli procura non pochi malumori. Seguono Asuba de su serbatoiu (2001) sulla chiusura di una fabbrica in Sardegna, Tempo vero (2001) sui problemi dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie; Volti – Viaggio del futuro d’Italia (2003), serie di sei documentari, mandati in onda su Rai3 dal gennaio 2004. Segre torna alla fiction con Vecchie (2002), film semisperimentale girato in bianconero con una telecamera ferma in una (apparente) unica inquadratura frontale e due donne in scena che parlano in vestaglia. Scritto con le due interpreti – Maria Grazia Grassini e Barbara Valmorin, esimie commedianti di lungo corso – e coprodotto con la “Pablo” di Gianluca Arcopinto, Vecchie è, in altalena tra l’ironico e il patetico, un film sull’amicizia, sul diritto all’ozio, sul tempo che è peggio di una lima, ma nel quale le ore dovrebbero essere fatte per l’uomo e non viceversa. Presentato nella sezione “Nuovi territori” a Venezia 2002, pluripremiato in altri festival, dal gennaio 2003 si trasforma nello spettacolo teatrale “Vecchie Vacanze al mare” che si replica con successo anche nella stagione 2004-05.
Nella regia teatrale Segre aveva esordito nel 1995 con Week-end di Annibale Ruccello, un’altra scelta significativa almeno per chi conosce la storia e la vitalità del recente teatro napoletano. Risalgono a quel periodo due mediometraggi, altre testimonianze della sua accanita coerenza tematica nell’ambito del cinema della realtà, seppur rivolta al passato, ma senza facili abbandoni alla nostalgia. Sono Non ti scordar di me (1995) sul microcosmo delle comparse di Cinecittà, descritto con una lucidità che non dimentica mai il rispetto ed evita il folklore, e Paveren fumighi (1997), storia di un doppio inizio girata a Cavriago (Reggio Emilia): si rievoca la costruzione, voluta dalla popolazione, di un cinema nel primo dopoguerra, poi chiuso una trentina d’anni dopo e riaperto negli anni ’90 col nuovo nome Novecento: «Segre mette in scena, la realtà, la rinascita dell’Italia, la ripartenza dopo la guerra, lo spirito collettivo che ha dato a questo paese le poche (non pochissime) cose di cui può andare orgoglioso» (Alberto Crespi).
Anche Mitraglia e il Verme (2004) si muove, come e più di Vecchie, sull’ambiguo confine che separa e congiunge il falso dal vero, la finzione dalla realtà. L’impianto drammaturgico è simile: due personaggi in scena, videocamera (digitale) immobile, rinunzia al montaggio. «sono convinto –dice Segre – che in questo modo sia più facile captare e rendere visibili momenti di autenticità che gli attori riescono a produrre sul set». Testardo cultore del cinema della realtà, Segre è un documentarista che ama gli attori. Sembra, ma non è un paradosso.
Anche le differenze sono evidenti. Intanto c’è la dinamica profondità di campo (fotografia: Marco Carosi). E la scenografia (Ivano Gargiulo) che, nello squallore dell’ambiente (i cessi pubblici dei Mercati Generali), ha una dimensione quasi metafisica. Non a caso in un’intervista lo stesso Segre parla di De Chirico, magari riletto con le lenti di Picasso. Se in Vecchie prevale un’amabile leggerezza, tinta di malinconia, qui c’è una cupezza stridula, nutrita di rabbia, che diventa metafora di tristi tempi, dominati dall’avidità e dall’incertezza. La resa attoriale dei caratteristi Stefano Corsi e Antonello Fassari è sotto il segno della simbiosi. Anche qui i due attori – e Antonio Manca, allievo di Segre al Centro Sperimentale – hanno collaborato alla sceneggiatura. Riferimenti culturali? Beckett, ovviamente, ma anche Fassbinder e qualcosa di Pasolini e Pinter. («Se posso, rubo tutto quello che è possibile» dice Segre). La sua scomoda sgradevolezza senza indulgenze né alibi l’hanno tenuto fuori dai festival di Venezia e Torino 2004. Selezionatori ottusi o troppo accorti?
Della mia amicizia con Segre – che ovviamente si è rafforzata negli anni 2000, da quando con lui e Antonio Costa dirigo il BellariaFilmFestival – ho già detto. In passato c’è stato un periodo in cui per fax ci scambiavamo poesie di autori amati. Ci divide il calcio: è un torinista irriducibile, oggi finalmente felice, mentre io sono lo strano caso di un milanese che fa un tifo piuttosto platonico per l’odiata Juventus fin dai tempi di Combi, Rosetta, Caligaris. Quando m’interrogano sul lavoro comune per il BFF, me la cavo con una metafora pedatoria: io sono lo stopper, Antonio Costa fa da centrocampista e Segre è il centravanti sfondatore alla Rombo di Tuono. Cerco di evitare con lui ogni disputa sull’insolubile dramma palestinese: non posso pretendere da chi, come lui, ha parenti in Israele, la lucidità di un distacco critico. Per rivalsa, lui mi stuzzica col tormentone che della triade bellariese sono il più amato dalle donne registe.
In un bel saggio del 1963 su Albert Camus (Un marito ideale) Susan Sontag scrive che i grandi scrittori sono dei mariti o degli amanti. Se si lascia da parte l’aggettivo, sollecitando dolcemente il testo, potrei dire che Daniele Segre fa parte, come regista, dei mariti perché ne ha le solide qualità: stabilità, intelleggibilità, generosità e correttezza.
Il cinema della realtà – fiction o non fiction – che da trent’anni ha sposato, lo dimostra. Tra quel che Sontag dice del grande scrittore francese almeno una frase s’addice a Segre: «Il tema della vita dell’opera di Camus non è tanto la moralità quanto il pathos delle posizioni morali. E’ qui la sua modernità». Anche nei suoi documentari meno scomodi – perché spesso i mariti sono più scomodi degli amanti in tempi in cui la musa principale è la perversità – il pathos del suo cinema nasce dal rispetto delle persone di cui si occupa.
Segre fa un cinema utile. Agli altri, ma non ai potenti.